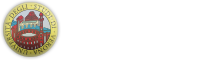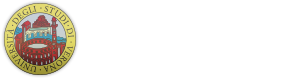Obiettivi formativi
Gli obiettivi formativi del Corso sono volti ad acquisire una conoscenza approfondita del contesto storico, culturale e letterario in relazione al corso impartito. Attraverso una buona padronanza degli strumenti metodologici comparatistici, il corso mira a fornire informazioni utili a commentare, interpretare, contestualizzare, storicizzare testi appartenenti a diversi generi letterari nonché a sviluppare capacità di analisi ermeneutico-critica.
Gli strumenti acquisiti si rivolgeranno a temi e topoi di lunga durata e appartenenti a letterature cronologicamente e topograficamente diverse. Al termine dell’insegnamento, lo studente dovrà dimostrare di aver acquisito conoscenze e competenze approfondite e adeguate a perfezionare un giudizio critico (knowledge and understanding); di aver maturato capacità di apprendere e di comprendere, necessarie a sostenere argomentazioni e spunti di riflessione, nonché abilità a eleborare idee personali (learning skills); di saper comunicare informazioni, tematiche nuove e problemi relativamente alla materia impartita (making judgements); infine di aver la capacità di integrare le conoscenze e gestirne la complessità con un alto grado di autonomia in contesti più ampi (o interdisciplinari) (communication skills).
Il corso presenterà e discuterà alcuni tra i più recenti sviluppi teorici e metodologici negli studi letterari, favoriti da interazioni interdisciplinari con
- scienze neuro-cognitive,
- estetica empirica,
- informatica.
Questi quadri teorico-metodologici saranno confrontati con tradizioni critiche come formalismo e strutturalismo, estetica della ricezione e critica psicoanalitica, new historicism e critica sociologica. L’analisi si concentrerà su rischi e opportunità nella combinazione di metodi di ricerca tradizionali con approcci quantitativo-sperimentali.
Ogni analisi sarà sviluppata attorno a uno o più casi di studio, con implicazioni in stilistica, narratologia, estetica, filosofia del linguaggio e storiografia letteraria, e con taglio spiccatamente comparatistico. I principali casi di studio saranno:
- la ricezione della storia letteraria italiana nei paesi stranieri;
- l’identificazione dell’“impronta autoriale” di scrittori come William Shakespeare, Robert Musil ed Elena Ferrante;
- le sperimentazioni formali di autori moderni e contemporanei come James Joyce, Thomas Pynchon, Roberto Bolaño e Claudio Magris;
- gli effetti della rivoluzione digitale sull’esperienza della lettura (lettura su carta vs. lettura su schermo, online social reading).
BIBLIOGRAFIA
INTRODUZIONI GENERALI
1. Enza Biagini, Augusta Brettoni e Paolo Orvieto (a cura di) 2001. Teorie critiche del Novecento: con antologia di testi. Roma: Carocci.
2. Raffaella Bertazzoli (a cura di) 2010. Letteratura comparata. Brescia: Editrice La Scuola [Introduzione; Parte 1: Capitoli 1-4; Parte 2: Capitoli 1-4].
3. Marco Bernini e Marco Caracciolo. 2013. Letteratura e scienze cognitive. Roma: Carocci.
4. Willie van Peer, Jèmeljan Hakemulder, and Sonia Zyngier. 2012. Scientific Methods for the Humanities. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Pub. [Capitolo 1, Interlude, Capitoli 2-4].
5. Susan Schreibman, Raymond George Siemens, and John Unsworth (eds.) 2016. A New Companion to Digital Humanities. Chichester: Wiley Blackwell [Capitoli 11, 17, 19, 20 e 23]
MATERIALI DI STUDIO (da discutere in classe)
1. Simone Rebora. 2018. History/Histoire e Digital Humanities. La nascita della storiografia letteraria italiana fuori d’Italia. Firenze: Firenze University Press. Online: http://www.fupress.com/catalogo/history-histoire-e-digital-humanities/3748 [Introduzione e Capitolo 3].
2. Massimo Salgaro. 2018. “The Digital Humanities as a Toolkit for Literary Theory: Three Case Studies of the Operationalization of the Concepts of ‘Late Style’, ‘Authorship Attribution’, and ‘Literary Movement’.” Iperstoria 12: 50-60. Online: http://www.iperstoria.it/joomla/images/PDF/Numero_12/Salgaro_pdf.pdf
3. J. Berenike Herrmann, Karina van Dalen-Oskam, and Christof Schöch. 2015. “Revisiting Style, a Key Concept in Literary Studies.” Journal of Literary Theory 9(1): 25-52. Online: https://zenodo.org/record/50893
4. Patrick Colm Hogan 2013. “Parallel processing and the human mind: Re-understanding consciousness with James Joyce’s Ulysses.” Journal of Literary Semantics 42(2): 149-164.
5. Petrus Van Ewijk. 2011. “Encyclopedia, Network, Hypertext, Database: The Continuing Relevance of Encyclopedic Narrative and Encyclopedic Novel as Generic Designations.” Genre 44(2): 205-222.
6. Franco Moretti. 2011. “Network Theory. Plot Analysis.” Stanford Literary Lab Pamphlets 2: 2-12. Online: https://litlab.stanford.edu/LiteraryLabPamphlet2.pdf
7. Massimo Salgaro. 2009. “L’opera letteraria si realizza nella coscienza del lettore. Estetica della ricezione, psicologia cognitiva e neuroscienze.” In Id. (a cura di). Verso una neuroestetica della letteratura. Roma: Aracne, pp. 142-165.
8. Anne Mangen and Adriaan Van der Weel. 2016. “The evolution of reading in the age of digitisation: an integrative framework for reading research.” Literacy 50(3): 116-124. Online: http://ereadcost.eu/wp-content/uploads/2016/11/Mangen-van-der-Weel-2016-The-Evolution-of-Reading-in-the-Age-of-Digitisation_An-integrative-framework-for-reading-research.pdf
9. Simone Rebora and Federico Pianzola. 2018. “A New Research Programme for Reading Research: Analysing Comments in the Margins on Wattpad.” DigitCult 3(2): 19-36. Online: http://www.digitcult.it/index.php/dc/article/view/67/62
10a. Fabio Ciotti. 2017. “Modelli e metodi computazionali per la critica letteraria: lo stato dell’arte.” In B. Alfonzetti, T. Cancro, V. Di Iasio, E. Pietrobon (a cura di). L’Italianistica oggi: ricerca e didattica. Roma: Adi editore, pp. 1-11. Online: http://www.italianisti.it/upload/userfiles/files/Ciotti.pdf
10b. Fabio Ciotti. 2018. “What Theory for Distant Reading in Literary Studies?” In EADH 2018 Conference Abstracts, pp. 1-3. Online: https://eadh2018.exordo.com/files/papers/91/final_draft/What_Theory_for_Distant_Reading_in_Literary_Studies-abstract.pdf
Materiali didattici e informazioni dettagliate sono disponibili sulla piattaforma Moodle.
Le modalità didattiche comportano lezioni frontali, da svolgersi in tre giorni settimanali per un complessivo carico di 54 ore (9 CFU). Durante le lezioni, gli studenti saranno incoraggiati a partecipare attivamente, tramite presentazioni alla classe e discussioni di tipo seminariale. Gli studenti non frequentanti dovranno concordare un programma con qualche variazione per facilitare lo studio individuale.
Gli studenti dovranno mostrare, durante un colloquio orale, di aver appreso le capacità critiche che si sono elaborate durante il corso, mostrando un’abilità analitica e argomentativa nel collegare i vari piani teorici e metodologici nell’interpretazione dei testi letterari. Lo studente dovrà altresì esporre con proprietà di linguaggio.