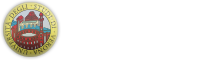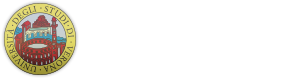Titolo del Corso – Editing Early Middle High German ‘Alexanderlied’: Digital Perspectives
Il programma è suddiviso in due parti principali, secondo lo schema qui sotto,
- la Parte A (12 ore) consisterà in un riesame degli aspetti interdisciplinari della Filologia germanica (critica testuale, incluso l’approccio digitale, linguistica storica, nascita delle lingue letterarie germaniche);
- la Parte B (30 ore) consisterà in un'introduzione ai problemi caratteristici delle tradizioni del medioevo volgare (sull’esempio del poemetto proto-medio-alto-tedesco noto come Alexanderlied);
- ai metodi e alle procedure della critica del testo tradizionale;
- all’edizione scientifica digitale
Durante il corso, lavorando sui facsimili digitali, gli studenti verranno guidati a leggere e a trascrivere (in forma diplomatica e normalizzata, secondo lo standard XML/TEI) uno dei testimoni dell’Alexanderlied.
LETTURE CONSIGLIATE
Parte A
Come riesame della storia della critica del testo:
David Greetham, ‘A history of textual scholarship’, in The Cambridge Companion to Textual Scholarship, ed. by N. Fraistat and J. Flanders, Cambridge: University Press, 2013;
Come rassegna degli aspetti principali della linguistica germanica, in prospettiva comparatistica e diacronica:
Robinson, Orrin W., Old English and its closest relatives: a survey of the earliest Germanic languages. Stanford, California: Stanford University Press, 1992.
Come rassegna degli aspetti principali dell’umanistica digitale:
Susan Schreibman, Ray Siemens, John Unsworth (eds.), A Companion to Digital Humanities, Oxford, Blackwell 2004:
<http://digitalhumanities.org:3030/companion/view?docId=blackwell/9781405103213/9781405103213.xml&chunk.id=ss1-3-2&toc.depth=1&toc.id=ss1-3-2&brand=9781405103213_brand>
The History of Humanities Computing;
Lexicography;
Linguistics Meets Exact Sciences;
Literary Studies;
How the Computer Works;
Databases;
Marking Texts of Many Dimensions;
Text Encoding;
Modeling: A Study in Words and Meanings;
Stylistic Analysis and Authorship Studies;
Preparation and Analysis of Linguistic Corpora;
Electronic Scholarly Editing;
Textual Analysis;
Thematic Research Collections;
Parte B
Per una rassegna della ricezione della leggenda di Alessandro Magno nel Medioevo:
Z. David Zuwiyya (ed.), A Companion to Alexander Literature in the Middle Ages, Leiden-Boston: Brill, 2011
Chapter 1: Richard Stoneman Primary Sources from the Classical and Early Medieval Periods;
Chapter 9: Laurence Harf-Lancner, Medieval French Alexander Romances;
Chapter 12: Danielle Buschinger, German Alexander Romances;
Chapter 13: David Ashurst and Francesco Vitti, Alexander Literature in Scandinavia
Per una rassegna delle problematiche critico-testuali, soprattutto in riferimento alle letterature volgari europee del medioevo, e delle prospettive digitali:
Elena Pierazzo, Digital scholarly editing: theories, models and methods, Farnham, Surrey: Ashgate, 2015
Susan Schreibman, Ray Siemens, John Unsworth (eds), A New Companion to Digital Humanities, Oxford: Blackwell, 2016
Willard McCarty, Becoming Interdisciplinary;
Lorna Hughes, Panos Constantopoulos, and Costis Dallas, Digital Methods in the Humanities: Understanding and Describing their Use across the Disciplines;
Julia Flanders and Fotis Jannidis, Data Modeling;
Elena Pierazzo, Textual Scholarship and Text Encoding;
Daniel Paul O’Donnell, Katherine L. Walter, Alex Gil, and Neil Fraistat, Only Connect: The Globalization of the Digital Humanities;
William G. Thomas III, The Promise of the Digital Humanities and the Contested Nature of Digital Scholarship;
Adele Cipolla (ed.), Digital Philology: New Thoughts on Old Questions, Padova: libreriauniversitaria.it, 2018
Thomas Bein, Walther von der Vogelweide: Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Edition seiner Texte;
Marina Buzzoni, Reconstruction vs Documentation: A Survey of Editorial Conundrums and (Ir)reconcilable Positions;
Adele Cipolla, Intractable Cases and Digital Hopes: How New Media Can Help with Interpreting Multi-Version Vernacular Texts;
Paolo Trovato, What if Bédier was Mistaken? Reflections of an Unrepentant Neo-Lachmannian
Modalità didattiche
Le modalità didattiche adottate non sono distinte tra studenti frequentanti e non frequentanti. Solo per i frequentanti, è previsto uno specifico test intermedio di autovalutazione dell’apprendimento, che avrà luogo durante le lezioni.
Durante tutto l’anno accademico, inoltre, è disponibile il servizio di ricevimento individuale gestito dal docente, negli orari indicati sulle pagine web (senza necessità di fissare un appuntamento, se non indicato da avvisi specifici) e costantemente aggiornati.
Gli studenti frequentanti riceveranno alla prima lezione il calendario completo delle attività didattiche con le date delle lezioni di cui viene fornito l’orario e l’aula. Eventuali sospensioni delle lezioni verranno comunicate tramite la piattaforma e-learning.
Gli studenti non frequentanti sono pregati di contattare la docente. Eventuali ulteriori aggiornamenti saranno resi disponibili in tempo utile allo studente anche mediante avvisi appositamente dedicati sulla piattaforma e-learning (alla quale tutti sono pregati di iscriversi).
Il contenuto dei libri di testo, nonché delle lezioni ed esercitazioni tenute in aula è aderente al programma. Ulteriore materiale didattico è disponibile sulla piattaforma e-learning dell’insegnamento.
L’esame si svolgerà in forma orale, nelle tre sessioni istituzionali previste per i corsi del Dipartimento di Lingue e Letterature straniere.
L’accertamento dei risultati di apprendimento prevede:
per gli STUDENTI FREQUENTANTI un accertamento preliminare scritto delle conoscenze acquisite con riferimento alla I parte del programma (prova in itinere) e una prova orale integrativa; - per gli STUDENTI NON FREQUENTANTI (che non hanno sostenuto i test di autovalutazione), una prova orale
Obiettivi delle prove di accertamento
STUDENTI FREQUENTANTI - A metà del corso (dopo la quinta settimana), per gli studenti interessati, sarà possibile sostenere una prova intermedia scritta (che sarà preceduta da una simulazione collettiva della prova stessa e discussione del gruppo, con autovalutazione), mirante a valutare le conoscenze acquisite sulla parte introduttiva del corso.
Alla prova intermedia è associato un punteggio espresso in 30esimi. La prova scritta si conclude con una proposta di voto che lo studente può integrare con la prova orale.
La prova orale integrativa consiste in un colloquio teso a sviluppare tutti gli aspetti trattati durante il corso.
La prova orale sull’intero programma (I+II parte) consiste in un colloquio teso a verificare
-la profondità e l’ampiezza delle conoscenze maturate;
- la proprietà di linguaggio;
- l’abilità di collegare in forma sistematica le conoscenze, su entrambe le parti del programma. Alla prova è associato un punteggio espresso in 30esimi (che farà media col punteggio della prova scritta).
STUDENTI NON FREQUENTANTI - La prova orale unica verte sull’intero programma (I+II parte) e consiste in un colloquio teso a verificare
-la profondità e l’ampiezza delle conoscenze maturate;
- la proprietà di linguaggio;
- l’abilità di collegare in forma sistematica le conoscenze, su entrambe le parti del programma.
La valutazione finale è espressa in 30esimi.
Gli studenti ERASMUS sono pregati di prendere contatto con la docente all’inizio dei corsi per concordare insieme le modalità didattiche e delle prove di accertamento.