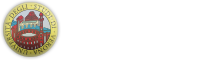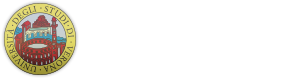20.III.2012 [7° lez.]: La figura del poeta tra simbolismo ed espressionismo: l’Abatros e il Cigno di Baudelaire (bellezza ed emarginazione; sublimità e Unbehaustsein [Rilke]); il poeta veggente, profeta, vates: lo Zarathustra di Nietzsche e il “pathos della distanza” – l’apostolo della rivoluzione: la poesia Der Dichter meidet strahlende Akkorde. La critica all’estetismo e il pathos rivoluzionario. Georg Heym (1887-1912): Der Gott der Stadt (il dio della città). Allegoria, grottesco (cfr. il procedimento della deformazione) e Farbsymbolik: l’uso emotivo del colore nella poesia e nella pittura espressionista (Franz Marc). L’ideale espressionista della visione vs l’ideale simbolista della Stimmung, dell’indeterminatezza e della nuance. Catastrofe (apocalissi) e resurrezione: il concetto chiave di Sturm [vento, tempesta] (cfr. la poesia Weltende [Fine del mondo] di Jakob van Hoddis). La critica espressionista alla psicologia e alla razionalità e il culto dell’irrazionale (cfr. implicazioni politiche).
21.III.2012 [8° lez.]: Farbsymbolik simbolista vs Farbsymbolik espressionista: uso realista-impressionista vs uso emotivo-visionario. La poesia e i colori: la storia del blu (dalla blauer Blume di Novalis al “blu insperato” di George alla blauer Stunde di Benn – cfr. il “complesso ligure”); il rosa di Rilke: la poesia Flamingos (e la poetica rilkiana della Verwandlung); la prevalenza del rosso e del nero nella poesia espressionista (Heym e Trakl) e la simbologia “apocalittica” di questi colori. La Zivilisationskritik nell’espressionismo: la poesia di Heym, i drammi di Kaiser (Gas I e Gas II) e la poesia di Benn, il film Metropolis di Fritz Lang. Il caso della poesia di Georg Trakl: a metà tra simbolismo ed espressionismo: il senso della catastrofe e dell’angoscia in Grodek e Klage (Lamento). Contrasto tra bellezza e deformazione/grottesco. Indeterminatezza delle immagini e della Farbsymbolik.
27.III.2012 [9° lez.]: Le visioni espressioniste: visioni metropolitane di Heym, visioni apocalittiche di Trakl, e quelle arcaiche di Benn (regressione e nosofilia). Morgue di Gottfried Benn (1886-1956): storia di una provocazione e di uno scandalo; il rapporto tra letteratura e medicina (poesia e anatomia); l’estetica del brutto. Schöne Jugend (Bella gioventù). La distruzione dei miti classici: bellezza e gioventù. Il motivo della bella ragazza morta. Sarcasmo e nihilismo. L’influsso di Nietzsche: la “trascendenza della voglia creativa”; l’arte come unico valore che sopravvive alla distruzione dei valori della tradizione. La poesia Negerbraut (Moglie di negro). Arte africano e avanguardia. La ricerca dell’idillio in un quadro di bruttezza e di morte: scena da matrimonio in un contesto repellente.
28.III.2012 [10° lez.] La lirica di Bertolt Brecht. Autobiografia poetica e messa in scena dell’artista in Vom armen B.B. (Del povero B.B.). Bertold Brecht e Gottfried Benn come figure guida della poesia del prima dopoguerra: la poesia politicamente impegnata e la “poesia assoluta”. An die Nachgeborenen (Ai posteri) di Brecht e Statische Gedichte (Poesie statiche) di Benn: due poetiche a confronto. La differenze nell’atteggiamento nei confronti di fronte alla storia e nel rapporto tra individuo e società: l’atteggiamento del saggio e il nihilismo da una parte; la lotta contro l’apatia e le ingiustizie sociali dall’altra.
17.IV.2012 [11° lez.] [Exkusus: lo scandalo recente suscitato dalla poesia Was gesagt werden soll di Günter Grass e la rinascita della poesia politica.] La poesia dopo Auschwitz. La provocazione di Adorno (“Scrivere poesie dopo Auschwitz è un atto di barbarie”) e la reazione dei poeti: la risposta di Enzensberger; Günter Grass: Askese. La concentrazione sull’essenziale e la rinuncia agli elementi superflui e decorativi. La polemica contro l’estetismo. Il dibattito sul pro e contro la metafora nel dopoguerra tedesco. Salvatore Quasimodo: Alle fronde dei salici (1948) e la nascita di una poesia civile in Italia.
18.IV.2012 [12° lez.]: Vergangenheitsbewältigung ed Erinnerungskultur nella Germania del dopoguerra. Poesia della memoria: Paul Celan e Nelly Sachs. Paul Celan: Todesfuge (Fuga di morte): la letteratura e l’olocausto; procedimenti metaforici e musicali – la realtà dei campi di concentramento. Nelly Sachs: O die Schornsteine (Oh, i camini); Chor der Geretteten (Coro dei salvati); In der Flucht (Nella fuga). Il difficile connubio di cultura ebraica e cultura tedesca. Il linguaggio biblico nella poesia. Il lavoro di Nelly Sachs sui miti biblici.
24.IV.2012 [13° lez.] La Naturlyrik di Oskar Loerke e il dibattito sulla lirica della natura nel dopoguerra. Ingeborg Bachmann e la critica alla società postbellica. Früher Mittag (mattino precoce): ripresa e straniamento della Naturlyrik e del Lied romantico. La delusione della speranza di rinnovamento, la continuità con il nazismo. La tematica dell’indicibile nella poesia del dopoguerra. Alle Tage (Tutti i giorni). La guerra in tempo di pace: il tema del fascismo privato. La critica alla retorica militare dell’eroismo e l’utopia di un eroismo civile.
24.IV.2012 [14° lez.] Lesung (lettura di poesia) di Daniela Seel dal suo libro: ich kann diese stelle nicht mehr finden (Berlin, Kookbooks Verlag, 2011).
27.IV.2012 [15° lez.] La poesia politica e la critica alla società postbellica: Hans Magnus Enzensberger. Die Verteidigung der Wölfe (La difesa dei lupi) La polemica contro il conformismo e l’industria culturale (in particolare contro la televisione); l’invito alla disobbedienza civile.
2.V.2012 [16° lez.] Il movimento del 68 e la poesia politica. Erich Fried: Und Vietnam und. La poesia 42 Schulkinder (42 scolari). Le poesie postume di Ingeborg Bachmann: Ich weiss keine bessere Welt (Non conosco mondo migliore). Letteratura e malattia: tre proposte di lettura delle poesie a partire dagli space studies (Michelle Perrot: Storia delle camere), dagli studi di Michel Foucault (Storia delle follia, Nascita della clinica) e da “malattia come metafora” (S. Sontag). La messa a fuoco della deformazione della percezione, della tematica del corpo e del(la rinascita del) culto religioso della figura del poeta.
9.V.2012 [17° lez.] Letteratura e topografia: lo spazio nella poesia. Letteratura e mito: la fortuna del mito dell’ apocalissi (Heym, Trakl e Brecht) e del diluvio nella poesia tedesca del dopoguerra: Erich Fried: Nach der Sintflut I; Nach der Sintflut II; Ingeborg Bachmann: Nach dieser Sintflut; Günter Grass: Hochwasser (Acqua alta).
Gli esperimenti del concretismo: Eugen Gomringer (Schweigen), Ernst Jandl e Friedericke Mayröcker. La scuola austriaca. La materialità della lingua. La critica all’uso stereotipato del linguaggio e la speranza di un linguaggio non alienato.
10.V.2012 [18° lez.] La lirica tedesca degli ultimi anni. Durs Grünbein. Gerade an solchen morgen (Giusto in mattine come questa); Schädelbasislektion (Lezione sulla base cranica), letteratura e medicina; Gedicht über Dresden (Poesia su Dresda).