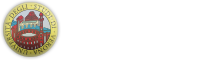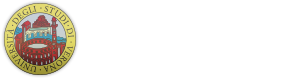La lirica tedesca del 900 (SS 2012): Programma
27.II.2012 [1° lez.]: Presentazione del programma: le grandi scansioni nella storia della lirica tedesca del 900. Introduzione consigliata: Wie interpretiert man ein Gedicht? (Stuttgart, Reclam): i metodi dell’interpretazione e la soggettività della lettura; la “classicità” del testo e la storia delle sue interpretazioni. La cultura del fin de siècle in Europa e il simbolismo. La centralità della cultura francese nella 2° metà dell’Ottocento. Parigi e il simbolismo francese (Baudelaire, Mallarmé, Rimbaud, Verlaine). La “provincialità” del simbolismo di lingua tedesca (George, Rilke, ma anche Pascoli) e il ruolo di Vienna (Hofmannsthal). Il culto del decadentismo e il senso della fine. L’estetismo di fine secolo: il rapporto tra bellezza e morale. La lezione di Nietzsche.
28.II.2012 [2° lez.]: La Wiener Moderne: la Jahrhundertwende come epoca d’oro della cultura austriaca: il movimento della Secessione (Klimt, Schiele, la Wiener Werkstätte), Freud e la psicanalisi, la filosofia delle impressioni di Ernst Mach e Arthur Schnitzler. Il ruolo della cultura ebrea. Hugo von Hofmannsthal come autore del jungen Wien (1890-1897) e della Kaffeehausliteratur (il caffè Griensteidl; Peter Altenberg, Stefan Zweig, Hermann Bahr, Karl Kraus). Die Ballade des äußeres Lebens (La ballata della vita esteriore). Il senso della crisi e il ruolo dell’individuo eccezionale (rispetto alle masse). Il contrasto tra la vita vissuta in modo superficiale e quella vissuta in modo profondo. Il culto dell’interiorità e il Weltgeheimnis.
6.III.2012 [3° lez.]: Hugo von Hofmannsthal come autore di libretti (per le opere di Richard Strauss), della commmedia Der Schwierige, del cosidd. Chandos-Brief sulla crisi del linguaggio. La poesia Manche freilich (Taluni, è vero): elitarismo e culto delle masse (cfr. culto dell’individuo eccezionale in Nietzsche). Il contesto storico: il ruolo delle masse tra 800 e 900, il socialismo e la paura della rivoluzione bolscevica in Europa. Il rapporto tra dolore, consapevolezza e (in)felicità in Manche freilich (cfr. la contrapposizione tra artista e borghese nell’opera giovanile di Thomas Mann). Artista e società dopo Baudelaire: status privilegiato ed emarginazione (cfr. L’albatros). La poetica dei paradisi artificiali. La poesia di Rainer Maria Rilke: Herbsttag; Der Panther (dalle Poesie nuove); Ausgesetzt auf den Bergen des Herzens.
7.III.2012 [4° lez.]: Stefan George e il George-Kreis: il progetto di rinnovamento culturale nel segno della tradizione, l’importanza del circolo nella cultura tedesca, il rapporto maestro-allievo e i suoi aspetti problematici (cfr. rapporto col Nazismo). L’ideale dell’esclusività nel rapporto col pubblico: culto del libro, politica editoriale, tipografia e scrittura. Il culto della bellezza (amorale) e della decadenza: la figura di Algabal. La raccolta Algabal (1892): l’affinità tra Jahrhundertwende e il Basso Romano Impero; la dedica a Ludwig II. George e D’Annunzio.
13.III.2012 [5° lez.]: La poesia Wenn um der zinnen kupferglühe hauben (Quando a cupole rogge a guglia e spalto). Il mondo artificiale di Eliogabalo. Esotismo ed esclusività; l’importanza del gesto “bello”; bellezza e (a)moralità. “Estetizzazione” della morte. La poesia Vogelschau. L’estetica degli animali esotici. Il paradiso artificiale come alternativa al mondo della natura. Caratteristiche formali della poesia (rima, ritmo, procedimenti retorici, etc.) La priorità della forma sul contenuto. La raccolta Das Jahr der Seele (L’anno dell’anima; 1907) e la nuova poetica. La poesia Komm in den totgesagten park und schau (vieni nel parco creduto morto e guarda): il concetto di parco come hortus conclusus, quello di autunno come stagione privilegiata del simbolismo (vs primavera: stagione privilegiata dagli espressionisti) e l’estetica della caducità. La “scuola dello sguardo” di George: la “desautomatizzazione della percezione”. Il rapporto tra natura, poesia e sentimenti (caducità ed eternità).
14.III.2012 [6° lez.]: Algabal: il rapporto tra bellezza, morte e (in)felicità (Weltanschauung pessimista). Le dimensioni dell’ideale georghiano della poesia pura: (1) perfezione formale e primato della forma (2) “assolutezza” della poesia: l’andare oltre il tempo e la storia nel segno della Dauer (3) sacralità della poesia (stretto rapporto tra arte e religione). L’immagine del poeta nel simbolismo europeo (il concetto di Autorschaft): il sacerdote, il veggente, il poeta vates (D’Annunzio). La figura del profeta e i suoi aspetti oscuri e problematici di questa: seduzione e manipolazione (cfr. il racconto Mario und der Zauberer [Mario e il mago] di Thomas Mann e la poesia Der Prophet di Hofmannsthal: il rapporto tra Hofmannsthal e George)