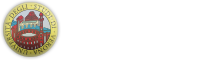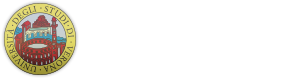Prof. Arturo Larcati: Teatro del Nocecento (SS 2011)
[22.II.2011] [1a] Vor Sonnenaufgang (Prima dell’alba) di Gerhart Hauptmann.
Lo scandalo della prima messa in scena nel 1889. La rottura colla tradizione del taetro idealistico. Il pessimismo naturalista: miseria e disperazione. Il crollo dei valori positivi, in particolare della famiglia. I drammi di Ibsen: I pilastri della società e Casa di bambola.
[23.II.2011] [2a] Max Reinhardt: il teatro come sogno, come festa e fantasmagoria. Le messe in scena di Shakespeare (Sogno di una notte di mezza estate) Frank Wedekind (Frühlings Erwachen). Le innovazioni teatrali di Adolphe Appia e Gordon Craig.
[1.III.2011] [3a] Il teatro del fin de siècle: Stimmung e Nuance psicologica al posto del Milieu naturalista. Anatol di Arthur Schnitzler. Il “dramma lirico” di Hugo von Hofmannsthal: Der Tor und der Tod (Il folle e la morte), Der Tod des Tizians (La morte di Tiziano). Il problema dell’estetismo: l’estraneità di fronte alla vita “autentica”.
[2.III.2010] [4a] Reigen (Girotondo) di Arthur Schnitzler: storia di uno scandalo. Il dramma espressionista (1914-1922 ca). Tre concetti chiave: Wandlungsdrama, Stationendrama, Verkündigungsdrama. Die Bürger von Calais (I cittadini di Calais) di Georg Kaiser e Die Wandlung (La svolta) di Ernst Toller.
[8.III.2011] [5a] Personaggi femminili del tetro tedesco del Novecento. Lulu di Frank Wedekind come icona della femme fatale. La fortuna della figura di Lulu nell’opera (Berg), nel cinema (Der blaue Engel) e nella fotografia (Otto Grosz). Männerphantasien (Theweleit) tra 800 e 900. Personaggi femminili e isteria: La signorina Else di Arthur Schnitzler ed Elettra di Hugo von Hofmannsthal. L’importanza della danza nel teatro del 900. Autrici femminili: Ingeborg Bachmann ed Elfriede Jelinek.
[9.III.2011] [6a] La scena “Die Frage an das Schicksal” in Anatol di Schnitzler: “esperimento scientifico” e problematizzazione del concetto di fedeltà. Reigen: struttura ciclica e universalità della promiscuità. Georg Kaiser: Von morgen bis Mitternacht. Masse Mensch di Ernst Toller. Die Wandlung (La svolta) di Ernst Toller. [letture: 3° atto di Von morgen bis Mitternacht – la scena nel palasport; la scena della “danza macabra” in Die Wandlung di Ernst Toller].
[15.III.2011] [7a] Brecht e la Repubblica di Weimar. La critica alla società capitalista e l’utopia socialista. L’opera da tre soldi di Bertolt Brecht. Lehrtheater e Unterhaltungstheater in Brecht. La ballata di Mackie Messer. Il prologo. Criminali e borghesi nella società capitalista.
[16.III.2011] [8a] L’opera da tre soldi di Bertolt Brecht. Teatro aristotelico e teatro epico. La critica al concetto di compassione (empatia) e la distanza critica richiesta allo spettaore. L’effetto di straniamento e il progetto di trasformare la società. La ballata di Jenny delle spelunche (dei marinai): la vendetta degli sfruttati contro gli sfruttatori.
[22.III.2010] [9a] Kurt Weill e Bert Brecht. Il ruolo della musica nell’Opera da tre soldi (il concetto di Misuk). Melodramma e musica popolare, jazz e swing. Ernst Bloch interpreta la ballata di Jenny delle spelunche: il tema dell’apocalisse. L’attualità di Brecht: teatro epico e Gefühlskultur.
[23.III.2010] [10a] La letteratura tedesca durante il Terzo Reich. Il comportamento di artisti e scrittori. La Exilliteratur. Mephisto. Roman einer Karriere (1936) di Klaus Mann e Doktor Faustus (1947) di Thomas Mann. La vita di Galilei di Bertolt Brecht. Il problema della bomba atomica. La figura di Galilei. La libertà della ricerca e il problema della verità. Galilei, il conflitto colla Chiesa e la ritrattazione delle sue posizioni. Le 3 versioni del Galilei. La 14° scena. L’ambiguità delle scoperte scientifiche.
[28.III.2010] [11a] Il teatro Svizzero e il suo successo nel 1962: tra il teatro dell’assurdo e il Dokumentartheater. Il grottesco. La tecnica poliziesca e quella della suspence. La poetica dei “mondi rovesciati”, l’inversione di normalità e follia. Il pessimismo.
[29.III.2010] [12a] Andorra di Max Frisch. Il carattere di modello o parabola della pièce. L’influsso di Brecht. Differenze tra Dürrenmatt e Frisch. Il contesto storico: la Svizzera durante il Terzo Reich. La diversità del protagonista. Il meccanismo del pregiudizio e della discriminazione/persecuzione del diverso. La 1° scena di Andorra. I meccanismi sottili della discriminazione. L’ipocrisia dei benpensanti, la prevaricazione sul diverso.
[5.IV.2010] [13a] Tre posizioni diversi di fronte all’atomica: il Galilei di Brecht, In der Sache J. Robert Oppenheimer di Heiner Kipphardt, I fisici di Friedrich Dürrenmatt. Il secondo dopoguerra tedesco e la grande stagione del radiogramma. La poetica del radiogramma: la costruzione di mondi onirici e la concentrazione sui pensieri e i sentimenti dei protagonisti; la musica. Ingeborg Bachmann e il femminismo. Malina e Todesarten: la tesi del fascismo privato. Il buon Dio di Manhattan (1958) di Ingeborg Bachmann. Il dramma analitico. L’amore come anderer Zustand o Grenzfall in una società omologata. Il ruolo della topografia e del Buon Dio nel radiogramma.
[6.IV.2010] [14a] La “cultura del ricordo” nel dopoguerra (come ricordare?) e il problema della sopravvivenza della mentalità nazista. Il teatro documentario e l’Istruttoria (1965) di Peter Weiss. Il problema del linguaggio (l’”indicibilità”, l’inenarrabilità dell’olocausto) L’uso di documenti storici. Il punto di vista delle vittime e quello dei carnefici. Il riferimento alla Divina Commedia e il progetto di un Welttheater. Il genere dell’oratorio.
[10.IV.2010] [15a] Proiezione della messa in scena dell’Istruttoria della Compagnia di Dall’Aglio al Teatro Due. Conferenza del Prof. Massimo Salgaro per commentare la messa in scena: l’approccio antibrechtiano del regista (gestualità, immedesimazione, presenza degli oggetti, musica). La differenza tra l’approccio semantico e performativo al teatro.
[3.V.2010] [16a] Le novità del teatro tedesco e austriaco degli anni Sessanta: Weiss (Dokumentartheater) e Peter Handke (Sprechstück). La diversa ricezione del teatro di Brecht da parte di Weiss e Handke: parabola vs sperimentalismo. Handke e il Gruppo 47 (la critica alla letteratura impegnata). La poetica del teatro sperimentale. Insulti al pubblico e la critica al teatro tradizionale. Kaspar. Il processo di socializzazione (educazione) linguistica porta alla distruzione della personalità dell’individuo e alla sua spersonalizzazione (omologazione): l’uso perverso (manipolativo) del luogo comune.
[4.V.2010] [17a] Thomas Bernhard come agent provocateur e l’Austria. L’autore, i suoi scandali e i suoi processi. La sopravvivenza della mentalità fascista in Austria: Heldenplatz (1988). Gli scritti autobiografici di Bernhard.
Bernhard e il festival di Salisburgo. Ein Fest für Boris (1970): un Anti-Jedermann. Lo smascheramento di una società ipocrita e sadica. Il tema della sofferenza, della malattia della morte (gli invalidi). Il totale pessimismo. La tecnica del monologo. Die Jagdgesellschaft (1974) la critica a una parte della società che si ritiene migliore e non vuole guardare in faccia alla realtà, rimuove la morte. Il mondo come teatro dove tutti recitano dei ruoli. La figura dell’artista (cfr. Der Theatermacher). Il procedimento del teatro nel teatro.
[4.V.2010] [18a] Th. Bernhard: la combinazione di malattia, morte e buffoneria. Il grottesco e la tragicommedia, l’ironia “nera” e il sarcasmo. (Exkursus: le forme di grottesco nel teatro del 20° secolo). Die Berühmten (1975): la presa in giro del mondo degli artisti. Perfidia, aggressività e follia degli artisti. Il tema del tradimento. T. bern. tra critica e identificazione. Der Ignorant und der Wahnsinnige (1972): musica, malattia, critica all’Austria e buffoneria. La bravura artistica e il problema dell’identità, del rapporto tra arte e vita. Lo sberleffo finale. Elfriede Jelinek: Krankheit oder moderne Frauen. Il rapporto uomo-donna e il femminismo. La poetica dell’intertestualità. Il grottesco e la tragicommedia. I luoghi comuni e l’identità femminile. Il vampirismo femminile. La ribellione delle donne. La reazione degli uomini. La marginalizzazione della donna nella società patriarcale. Il pessimismo totale di E. Jelinek.